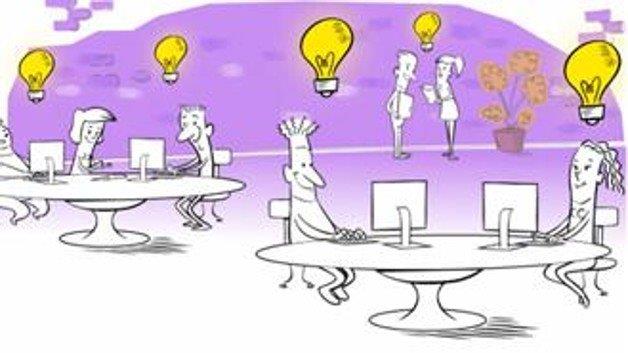Impatto delle recenti trasformazioni
Le trasformazioni avvenute negli anni Novanta del Novecento hanno profondamente modificato il mondo dell’artigianato, rendendo obsoleta la visione tradizionale che continua a sopravvivere nel senso comune, che non ha più una corrispondenza con la realtà. La visione comune lega l’artigiano soprattutto a delle abilità manuali, ad un saper fare che si apprende nella pratica, nel lavoro di “bottega”. Nell’immagine collettiva – la quale non considera che tra i “nuovi artigiani” moltissime sono donne – va a fare l’artigiano chi non ha voglia di studiare e va ad imparare un mestiere, o direttamente in bottega, o frequentando una scuola di formazione professionale o di avviamento al lavoro.
L’istruzione superiore cosiddetta tecnica è stata da sempre caratterizzata da una dicotomia: da una parte i licei, dall’altra le scuole di arti e mestieri considerate le cenerentole dell’istruzione. Tutto ciò, oltre ad avere conseguenze negative nel rapporto tra la scuola e la società, è legato ad una concezione che assegnava ed assegna all’artigianato un ruolo marginale e residuale nello sviluppo dell’economia di un paese. Una visione alla quale ha contribuito in modo determinante il racconto fatto della storia dello sviluppo industriale che, essendo tutta incentrata sulla grande impresa, non dà la giusta rilevanza ai distretti e alle medie imprese di successo né tantomeno mette in evidenza l’importanza dell’artigianato.
Gli esiti dello sviluppo socioeconomico hanno messo in luce l’insufficienza di questa visione, che non è stata capace di cogliere le specificità dell’assetto produttivo di molti paesi dell’Europa. Un assetto profondamente caratterizzato da un artigianato calato nel territorio, capace di intercettare le opportunità offerte dalla rivoluzione informatica. Il punto debole si può invece individuare nella perdurante separazione tra scuola e lavoro, nella difficoltà di armonizzare i due aspetti fondanti della formazione: teoria e pratica. E questo andrebbe fatto a tutti i livelli, università inclusa, quindi anche tra scienza e tecnologia, ricerca e industria.
Cultural and social capital of crafts
L’artigiano, in modo spontaneo, incarna da sempre l’incontro tra sapere e lavoro, intelligenza e abilità professionale. In particolare le fasce più avanzate di giovani artigiani, al passo con la rivoluzione tecnologica, dimostrano grande spirito di iniziativa ed elevata propensione all’innovazione ed all’autoimprenditorialità. Nei nuovi scenari globali che impongono un rapido spostamento verso produzioni di qualità, con enormi possibilità di mercato, l’artigianato può giocare un ruolo di primo piano. Esso non è affatto residuale ma si inserisce perfettamente in un modello di organizzazione economica, vitale ma ignorata dall’informazione. In questo contesto, più del capitale finanziario e del potere politico, su cui ha fatto leva la vecchia borghesia industriale, contano:
[bullet_list icon=”play” indent=”10px” style=””]
- il capitale culturale, ossia le abilità e capacità professionali, le competenze, la creatività e lo spirito di iniziativa, l’autostima derivante da attività portatrici di senso
- il capitale sociale, ossia la capacità di creare reti di relazioni (una caratteristica ben presente nell’artigianato storico e che può essere ripresa su nuovi livelli e ambiti più vasti nell’epoca delle comunità immateriali)
[/bullet_list]
I giovani artigiani si collocano sempre più in questa prospettiva di sviluppo. Questo è ancora più evidente nei nuovi mestieri. Infatti, le attività legate alla net-economy e alle nuove tecnologie richiedono spesso limitati investimenti in capitale fisso e si possono avviare con un relativamente basso capitale economico iniziale. Ma al contempo queste attività richiedono un forte capitale personale e relazionale che rende coloro che operano in questo settore dei veri e propri “artigiani della conoscenza”.
Ma anche l’artigianato dei settori tradizionali, non più legato ad un ristretto mercato locale, si è trasformato, riuscendo a coniugare il saper fare con il saper comunicare, in linea con gli imperativi di una modernità in continua trasformazione che premia i fattori immateriali, tanto nella produzione quanto nel consumo.
Nonostante la ancora scarsa percezione che se ne ha all’esterno, il mondo dell’artigianato si è evoluto profondamente. L’artigianato moderno è un’attività che gode di prestigio e che non ha nulla da invidiare alle altre professioni. Anzi, può essere preferibile perché consente di realizzare aspirazioni e valori che si sono diffusi nelle fasce d’età più giovani: l’autonomia, l’autorealizzazione, l’affermazione di sé, la possibilità di coniugare reddito e senso. Anche la fisionomia dell’impresa artigiana sta cambiando. Mentre tradizionalmente era su base famigliare con trasmissione del mestiere dal padre al figlio, nelle imprese di nuova creazione prevale l’associazione tra amici, tra persone che hanno avuto esperienze in comune di lavoro dipendente o parasubordinato.