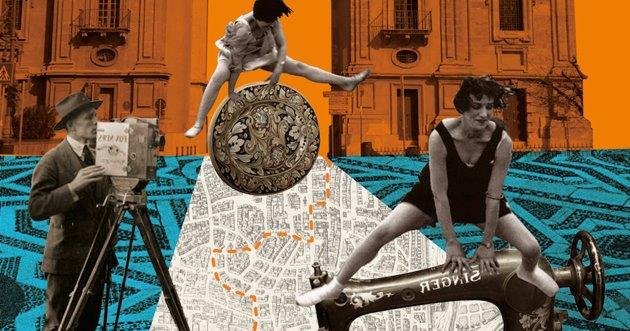Rinascita dell’artigianato
La rivincita sociale dell’artigianato è un fenomeno relativamente recente, e su cui non c’è adeguata letteratura, a differenza delle PMI e dei “distretti”, molto considerati a livello economico-sociologico e anche dal giornalismo economico. Va però detto che la sola lettura economica non consentirebbe di cogliere le specificità più rilevanti del nuovo artigianato. Le moderne attività artigianali, in continuità con i mestieri del passato, pur essendo aggiornate tecnologicamente o operando nel campo delle nuove tecnologie, non hanno come obiettivo esclusivo di fare business, come le grandi imprese. L’impresa artigiana è lo strumento per creare qualcosa di significativo partendo da una semplice idea, per dare una dimensione più umana al lavoro, per avere la soddisfazione di creare qualcosa che possa servire a qualcun altro.
Nell’autopercezione dei nuovi artigiani è molto forte il concetto del fare qualcosa di importante perché frutto del proprio lavoro manuale-intellettuale. Ci può essere chi lavora di più con le mani e chi usa prevalentemente il cervello ma non c’è separazione tra le due cose. L’idea di base è che l’artigiano esprime una autonoma capacità creativa. In un certo senso la cosa a cui tiene di più è l’autonomia. In questa fase di rinascita l’artigiano è lontano sia dalle forme organizzative tipiche del lavoro dipendente che da quelle corporative dei suoi antenati. Antropologicamente è un campione di individualismo, aperto a molteplici relazioni: funzionali, economiche, sociali, purché non ne intacchino l’autonomia, lo spirito di iniziativa, l’attitudine al rischio.
Di contro il mondo dell’artigianato è debole politicamente e incontra gravi problemi nel rapporto con le banche e il capitale finanziario. La mancanza di visibilità rappresenta l’ostacolo principale che ha di fronte l’intero comparto, non facile da superare perché è portatore di pregiudizi culturali e ideologici consolidati, divenuti oramai senso comune. L’idea prevalente è che l’artigiano si muova in una sfera strettamente locale, che i suoi clienti e committenti appartengano al territorio di cui l’artigianato, in molti casi, è l’espressione. I dati macroeconomici ci dicono che non è così. Un elemento sembra in particolare significativo: l’apporto complessivo di un questo comparto, ovunque in Europa, è pressoché ignorato dal dibattito pubblico, non ne conosciamo la performance complessiva. Gli artigiani europei che guardano all’export lavorano sia in settori di punta sia in settori tradizionali e curano in particolare il livello qualitativo della loro produzione, consentendo loro di posizionarsi sulle fasce alte del mercato globale. Questa scelta, da un lato, avvantaggia le quantità poco elevate di prodotti che un’impresa artigiana può realizzare, dall’altro, elude il rischio di una concorrenza basata sul prezzo da parte di competitori extra-europei. Tale posizione competitiva, per essere mantenuta e consolidata, richiede però politiche attive di sostegno, a partire dalla formazione. Gli altri infatti imparano in fretta e in ogni cultura vi è un retaggio storico caratterizzato da una ricca e varia tradizione artigianale, che può essere rilanciata e valorizzata nel contesto della circolazione globale di uomini e merci.